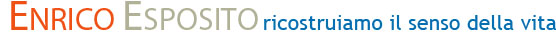
LETTERATURA E RISORGIMENTO IN CALABRIA
La letteratura calabrese per tutto il Risorgimento, e cioè dalla Repubblica napoletana del 1799 alla spedizione dei Mille, si caratterizza, in non pochi casi, per lo stretto legame instaurato tra vita e poesia, tra fantasia e realtà, tra ispirazione artistica e impegno politico. Un tratto che appare dominante soprattutto tra i poeti. E sarà proprio uno di questi poeti, Biagio Miraglia di Strongoli (1823-1885), a indicare le condizioni della poesia nel Mezzogiorno, in una classificazione che si presta benissimo a descrivere lo stato della letteratura in Calabria. Miraglia divide i poeti del “napolitano” in tre macro gruppi: “i poeti metafisici, i poeti locali e municipali ed i poeti scompigliati”. Mentre i primi molto concedono ad una sorta di astrattismo di idee e forma, con grande cura degli aspetti stilistici e tecnici, i poeti locali si chiudono nel loro”santuario domestico”, nel canto dei valori della famiglia patriarcale e nel gusto bozzettistico della rappresentazione di caratteri popolari e della descrizione dei colori dei luoghi, mentre gli scompigliati, dice Miraglia, “perché di fantasia torbida, disprezzano ogni regola, e le cose più lontane e tenzonanti accostano arbitrariamente e mostruosamente”.
In questo quadro , attraversato da intellettualismo classicistico e romanticismo di maniera, appare in Calabria un altro gruppo di poeti, animati da sentimenti originali e autonomi, profondamente legati alle speranze e alle attesa di cambiamento sul piano politico e, in qualche caso, su quello sociale ed economico. Lavorano nell’indifferenza generale e quasi nell’anonimato, e nei primi anni Settanta dell’Ottocento, e cioè più di dieci anni dopo la liberazione del Mezzogiorno dai Borbone, potranno occupare un posto di rilievo nel panorama letterario meridionale.
Solo negli anni 1872-73, infatti, Francesco De Sanctis parla per la prima volta di “romanticismo naturale calabrese”, confrontandolo con quello convenzionale dei poeti napoletani, che il grande critico della letteratura italiana individua in alcuni poeti formatisi alla sua scuola e ai suoi insegnamenti di estetica. Si tratta di Giuseppe Campagna, di Serrapedace (1799-1868), Pietro Giannone di Acri (1806-1869), Vincenzo Padula, anche questo di Acri (1819-1893), Domenico Mauro si san
Demetrio Corone (1812-1873), Biagio Miraglia, e ancora Vincenzo Gallo Arcuri, nato a Rocca di Neto (Catanzaro) nel 1826 e morto nel 1873. Particolare attenzione merita poi quello che è stato definito da Pasquino Crupi “il focolaio di Acri”
Intanto va rilevato che in questa schiera di poeti è costante il riferimento al modello byroniano, che trova nel paesaggio calabrese, e in special modo in quello silano, nelle sue foreste impenetrabili e horror, la sua ambientazione naturale. Inoltre di lord George Gordon Byron (1788-1824) un po’ tutti i poeti citati riprendono nei loro versi l’abbandono compiaciuto al crimine e all’incesto, la scelta estrema del brigantismo esasperata fino al satanismo. E tuttavia trasposto in Calabria il bandito subisce una metamorfosi di tipo schilleriano, diventando da gentiluomo con trascorsi tenebrosi e da vittima di soprusi e delitti efferati nell’ambito della famiglia, il difensore di nobili ideali, che tuttavia sceglie di perseguire con il delitto stesso, riscattato alla fine da pentimento sincero persino con il ricorso a pratiche devote. Un esito questo indotto da quello che per Marco Praz è la penetrazione di idee umanitarie nella letteratura calabrese dell’Ottocento. “Gli eroi di Byron” osserva a questo proposito Pasquino Crupi “vengono edulcorati, i briganti dei letterati calabresi, pur sotto apparenze demoniache, sono vittime e carnefici della società. Del resto, quei briganti erano una funzione della lotta politica che quel manipolo d’intellettuali calabresi conduceva contro i Borboni”.
Letteratura, cospirazione e politica
In effetti troviamo questi giovani educati alla scuola del De Sanctis impegnati su più di un fronte cospirativo e insurrezionale, tanto che di loro si dice spesso che vivono tra un verso e una barricata. Per loro poesia e politica sono strettamente connesse sulla base comune di una scelta di campo conseguente, a sostegno delle battaglie assolutistiche e indipendentische, nella prospettiva dell’unificazione dell’Italia in un solo Stato. In loro più che mai si evidenzia il carattere distintivo del Risorgimento, inteso come realizzazione del diritto della nazione italiana a costituirsi in stato indipendente e libero, nelle forme costituzionali ancora da definire e subordinate al confronto tra repubblicani e monarchici, liberali e democratici.
E così li ritroviamo presenti e attivi nei moti calabresi dal 1844 al 1847, e successivamente nella ricerca di nuove vie rivoluzionarie dopo la crisi seguita al fallimento degli esperimenti del ’48 e della repubblica romana e infine di quella veneziana, negli stessi anni in cui pubblicano le loro opere. In verità alcune di queste opere appaiono ancor prima. Giuseppe Campagna propone il suo Abate Gioacchino nel 1838, Pietro Giannone pubblica nel 1839 la Lauretta e Vincenzo Padula dà alle stampe Il Monastero della Sambucina nel 1842 cui seguirà tre anni dopo il Valentino. Nel 1844 appare a Napoli il Brigante di Biagio Miraglia e un anno dopo l’Errico di Domenico Mauro.
Il genere prescelto è quello della novella in ottave, ariostesca nella forma, manzoniana nell’ispirazione, con innegabili richiami petrarcheschi. Si parla a questo proposito di derivazione dal romanticismo lombardo, in quanto tale tipo di novella si vuole introdotta in Italia da Tommaso Grossi (1790-1853) con l’Ildegonda, ma è indubbio che si deve al Byron se la si pratica un po’ in tutta Europa.
In questa sede ci limiteremo a riprendere la novella in versi di Domenico Mauro, Biagio Miraglia e Vincenzo Padula, in quanto in questi tre poeti si evidenzia maggiormente la stretta correlazione tra poesia e attività rivoluzionaria.
Domenico Mauro, liberale in politica e romantico in letteratura
Proviene da san Demetrio Corone, e precisamente dal Collegio Italo-Albanese di sant’Adriano, una vera palestra di formazione politica agli ideali di libertà e indipendenza in vista dell’unità d’Italia. Partecipa con grande convinzione ai moti calabresi ed opera fin dall’inizio una scelta assoluta anche sul piano sociale. E’ un aristocratico, ma si schiera dalla parte dei contadini sul tema dei terreni demaniali, mentre non dimostra alcuna fiducia nella borghesia meridionale e calabrese, che gli appare incapace di concepire alcuna volontà di reale mutamento sul piano sociale e istituzionale. Conosce il carcere fin nel 1843 e nel 1847, prima a Cosenza e poi a Santa Maria Apparente, a Napoli. Appena rimesso in libertà è parte attiva con funzioni di comando e di direzione nel movimento calabrese del 1848. Infatti partecipa ai moti del ’48 fin dall’inizio e, dopo che il re di Napoli concede la Costituzione, viene eletto deputato al parlamento. Ma il 15 maggio di quell’anno il re non tiene fede alla parola data e Mauro firma il manifesto di protesta di Pasquale Stanislao Mancini, insieme ad altri 63 esponenti, e va sulle barricate, per rientrare subito a Cosenza dove entra a far parte del Comitato voluto dal Circolo Nazionale con l’incarico di responsabile del distretto di Castrovillari insieme con Nunzio Pace. In seguito nel governo provvisorio presieduto prima dal Valentini e poi da Giuseppe Ricciardi, assume incarichi di rilievo politico e militare insieme con Benedetto Musolino. Nella resistenza alla controffensiva borbonica è a Campotenese, dove le sue truppe vengono disperse, mentre la rivoluzione viene sconfitta in tutta la Calabria. Mauro s’imbarca per Corfù e da lì passa in Albania con l’intenzione di rientrare in Calabria, al seguito di Garibaldi in procinto di penetrare negli Abruzzi. Ma il disegno fallisce e allora si reca a Roma dove vive l’esperienza della repubblica con Giuseppe Mazzini. Fallito anche questo tentativo, emigra a Marsiglia e infine a Torino, dove si ricongiunge con tanti altri esuli calabresi. Partecipa poi alla spedizione dei Mille e, dopo l’unificazione, viene eletto deputato. Ma l’esito moderato del Risorgimento italiano è per lui una grande, cocente delusione. In Parlamento denuncia i limiti antimeridionali della raggiunta unità d’Italia, avvertita come tradimento della rivoluzione democratica italiana. Si chiude così in uno sdegnato isolamento, non cede alle lusinghe del potere, fedele ai suoi principi radicalmente liberali e democratici sulla base del mazzinianesimo più conseguente, ma riesce almeno a vedere realizzato con la breccia di Porta Pia il sogno di Roma capitale.
L’opera sua maggiore resta l’Errico del 1845, poi ristampata nel 1869, non più come “novella calabrese”, ma come poemetto in cinque canti, a riprova dell’esaurimento dell’ispirazione romantico-risorgimentale. E’ la storia di un brigante, diventato tale per la grave offesa arrecata al suo onore con la seduzione della moglie dal suo amico Arnoldo. Errico si rintana in Sila dove prepara la sua vendetta. Ma una volta davanti al suo nemico non riesce ad ucciderlo e insieme con lui piange la morte del figlio caduto da un muro. Infine si dà la morte, per essere ormai rimasto, senza figlio, senza onore, senza moglie. I briganti sospettano invece di Arnoldo, lo catturano e gli impongono di uccidere il proprio figlio. Ma la testimonianza della moglie Elisa vale a salvare il bambino ma non Arnoldo che viene ucciso, mentre la moglie di Errico soccombe anche lei, ed Elisa rimane sola, pur salva e rinsavita.
E’ una fosca tragedia di amore e morte, in cui domina il senso dell’onore come retaggio barbarico dell’uomo, un’idea vaga di giustizia popolare e sommaria, e ancora il carattere sacro della famiglia e la figura della donna, titolare solo di doveri connessi al focolare domestico, primo fra tutti la fedeltà. Byron è presente in grande misura, ovviamente, ma il brigante del Mauro non pianta le sue radici nelle ragioni politiche e sociali, quanto nel carattere sanguigno dei calabresi, portati naturaliter alla ribellione e al brigantaggio appunto.
Mette conto parlare di Mauro, critico dantesco, per le ricadute politiche che denotano la sua lettura del poema di Dante. Allegorie e bellezze della Divina Commedia (1840) e Concetto e forma della Divina Commedia (1862) sono tutta un’opera di denuncia politica. Il bersaglio è sempre l’ostilità della Chiesa al Risorgimento, ma anche l’oppressione straniera in Italia. Due male bestie che saranno sconfitte dal Veltro. Ma mentre Vincenzo Gioberti e i neoguelfi lo individuano nel papa liberale, presto ritornato al più vieto assolutismo, Mauro vede il veltro in un principe italiano. E subito dopo avverte che corretta lettura dell’opera di Dante è quella che considera la Divina Commedia un poema allegorico-didascalico.
Sopravvive ai miti del ’48, ma negli ultimi anni si accentua in lui il distacco dalla realtà concreta, nel vagheggiamento di sogni liberali e democratici per i quali il popolo spesso richiamato dal poeta non di rado manca all’appello.
Biagio Miraglia, il cronista della rivoluzione
“Ramingo di terra in terra, finché spunti il sole dei giorni profetizzati, io consolo le ore penose dell’esilio, raccontando all’Italia i tuoi fortissimi fatti. Le mie forze sono impari; il mio ingegno è debolissimo, ma il mio cuore, che anelò di morire sugli spalti delle tue mura, questo cuore, o eterna Roma, è degno di te”. Così scrive Biagio Miraglia, barone di Strongoli, l’antica Petelia, dopo che s’è consumato l’esperimento della repubblica romana di Mazzini, Salfi e Armellini. Le truppe francesi hanno schiacciato i volontari comandati da Garibaldi. Il sogno della repubblica nella città di Pio IX è tramontato per sempre, mentre la reazione assolutista si rafforza dappertutto in Europa. Miraglia, il poeta calabrese molto considerato da De Sanctis per la novella in ottave Il Brigante, è costretto all’esilio. Si rifugia negli Stati sardi, a Genova, dove fin dal dicembre del 1849 inizia a scrivere la ponderosa Storia della Rivoluzione Romana, pubblicata due anni dopo nel capoluogo ligure presso l’editore Bertocci. A Roma il barone di Strongoli ha lavorato all’ufficio stampa della repubblica mazziniana e ha partecipato a più di un’operazione militare. Dalla Calabria ha portato Oltretevere una grossa esperienza cospirativa e rivoluzionaria. A Cosenza in particolare è stato direttore di L’Italiano delle Calabrie, organo ufficiale del Comitato di Salute Pubblica, costituito dopo i fatti del 15 maggio 1848. Con Domenico Mauro e Benedetto Musolino è stato una delle figure più importanti del moto rivoluzionario calabrese. Alle correnti liberali e indipendentiste s’era accostato con opzioni di tipo neoguelfo e giobertiano, sperando come tanti italiani in Pio IX, che nelle giornate rivoluzionarie cosentine definisce “fondatore dell’indipendenza italiana”. Esauritosi il moto rivoluzionario calabrese, si rifugia a Roma, per entrare nell’orbita mazziniana, deluso dalle scelte di Pio IX durante la prima guerra d’indipendenza. Della repubblica romana narra i fatti forse con eccessiva puntualità diaristica, ma con grande passione politica. Nell’esperimento rivoluzionario di Mazzini – scrive nella prefazione alla sua Storia – ha potuto assistere allo scontro tra due dispotismi, che “pesavano da secoli su la cervice degli uomini, il dispotismo de’ Re e il dispotismo de’ Papi”. Un dramma “sublime”, in cui “s’è veduto un popolo che rovescia un tiranno dal Soglio, ma s’è veduto ancora il genio della moderna civiltà che fuga dal santuario le tenebre del medio evo.” Le illusioni su Pio IX e Gioberti sono definitivamente cadute e il poeta di Strongoli non si risparmia in accuse e invettive contro chi aveva salutato come l’unica speranza di riscatto del popolo italiano dall’oppressione straniera. A suo parere a Roma “s’è veduta la democrazia, come la santa religione di Cristo, sorgere dalle catacombe, piantare la sua fiaccola inestinguibile su la cima del Campidoglio e sfolgorante di luce assidersi sugl’infranti rottami del trono de’ Papi”. Un’esperienza, quella romana, vissuta nell’antitemporalismo senza avversione alla religione, ma nel rifiuto dell’assolutismo papale, secondo gli insegnamenti di Mazzini. Dopo la caduta di Roma, in un primo tempo partecipa a Genova al dibattito fra gli esuli meridionali sulle prospettive di ripresa del movimento indipendentiste. La vita da esule a Genova non è certo agevole e non è priva di umiliazioni e sofferenze, ma quando si trasferisce a Torino ed entra nell’entourage cavouriano le cose cambiano. Nella crisi del ’60 è fra gli emissari del governo di Torino a Napoli, durante la dittatura garibaldina, impegnato a contenere le istanze sociali e poltico-istituzionali connesse all’impresa dei Mille. Dopo l’Unità, diventerà funzionario di governo e morirà prefetto del nel 1885 a Roma.
Era nato a Strongoli nel 1823 e s’era formato nel collegio italo-albanese di Sant’Adriano a San Demetrio Corone. Il padre l’aveva mandato a Napoli perché abbracciasse la carriera ecclesiastica, ma il giovane aderì ben presto alla Giovine Italia e si dedicò all’attività cospirativa e rivoluzionaria in Calabria. Intanto nel 1844 aveva pubblicato a Napoli Il Brigante, nelle Edizioni dell’Ancora, e in segutio pubblicherà le Cinque Novelle Calabresi, nel 1856. L sua attività letteraria proseguirà con scritti di vario impegno critico e culturale, sulle prospettive della letteratura italiana.
E’ sempre stato avverso al regionalismo in letteratura, convinto com’è che esso “non è negazione della nazione, ma strada più rapida e più sicura ad essa.” e che “l’Italia non sarà nazione finché le mebra disgiunte di questo gran coropo non cominceranno a conoscersi e, se non politicamente, almeno idealmente, a compenetrarsi”.
La sua opera maggiore, Il Brigante, modellata sul Manzoni nei contenuti e su Ariosto e Petrarca e Dante, pur nella forma della novella romantica, narra la storia tragica di Carlo, a cui il conte Alfrido uccide la madre che non ha voluto cedere alle sue avances. Il giovane diventa brigante e s’innamora di Elisa, una sua compagna d’infanzia, promessa, contro la sua volontà, proprio al conte assassino. Carlo penetra con i suoi briganti nel palazzo di Alfrido e lo uccide. Ma nello scontro perisce anche Elisa e Carlo diventa frate cappuccino. E gli toccherà di confessare il padre della ragazza in punto di morte. Gli chiederà di perdonarlo per l’uccisione della figlia e il vecchio dopo una debole resistenza cede e perdona. E la novella si chiude con il pianto di tutti i protagonisti che perdonano e si rifugiano nella religione. Una storia edificante insomma, secondo il modello delle vite dei santi. Sullo sfondo la malvagia genia dei baroni oppressori su una massa contadina condannata al brigantaggio, che il poeta presenta senza rinunciare a qualche accenno populista forse ineliminabile nella materia prescelta. Dove dominano soprusi, senso dell’onore, vendetta e perdono, pur dopo il tanto sangue versato.
Vincenzo Padula, un prete liberale e anticonformista
Il più importante dei romantici calabrese è appunto Vincenzo Padula, di Acri. Avviato al seminario, non senza frequenti ripensamenti, cede spesso al fascino femminile, persino poco dopo essere stato ordinato sacerdote. Per questo la Chiesa gli proibisce di dir messa e gli vieta l’insegnamento nei seminari. E così è costretto ad aprire una scuola privata a San Marco. Ma siamo nel 1848 e la rivoluzione calabrese lo chiama a Cosenza, tra gli indipendentisti e gli antifeudali. Fallito l’esperimento rivoluzionario cosentino, cerca di reintegrarsi nel regime borbonico, addirittura negando di aver partecipato al movimento antiborbonico. Il suo sogno è quello di andare a insegnare a Napoli, ma incontra molti ostacoli e solo nel 1854 riesce a fissare la sua dimora nella capitale del regno borbonico. Intanto ha già pubblicato Il Monastero della Sambucina, nel 1842 e il Valentino nel 1845. Deve però aspettare il 1862 per essere nominato docente nel liceo di Cosenza, dal ministro della pubblica istruzione dell’epoca, e cioè da Francesco De Sanctis.
Il Monastero della Sambucina
E’ una novella calabrese anche questa, anche se di calabrese si riscontra essenzialmente il topos dell’onore violato e della fedeltà mancata da parte di donne che vengono rinchiuse in convento per espiare e pregare. Ma sia Teresa sia Gabriella pregano senza espiare. Anzi l’urgenza della carne si fa sentire ancora di più nelle celle del monastero. Gabriella spasima ancora per il suo giovane amante, che continua a incontrare, evadendo spesso dal convento. Poi il giovane muore in un duello con il padre di lei. La vita nella Sambucina non viene rischiarata dalla fede né mitigata dal tempo. La novella si chiude con la morte della piccola Eugenia, monacata contro la sua volontà e alla fine Teresa scopre che è figlia di Gabriella, grazie alla rivelazione della madre badessa.
Ci sono taluni aspetti che ricordano l’Ermengarda di Manzoni e la protagonista della novella di Grossi, ma il clima dominante è quello byroniano, con la variante tutta paduliana della novella nera condotta secondo i moduli del romanzo giallo, una tecnica del tutto nuova per quei tempi.
Valentino
Sesso e sangue in eccesso si ritrovano nella storia di Valentino, attraversata dalla repellente pratica dell’incesto. Valentino è un personaggio demoniaco, ha rapporti sessuali con la madre e uccide il padre. Poi concepisce rapporti incestuosi con la sorella e si uccide quando questa viene colpita senza volerlo dal suo pugnale. Un suicidio non vissuto come riscatto, ma come estrema manifestazione del demonismo byroniano. Per il resto Valentino è ispirato al realismo più crudo, quello della vita violenta dei briganti calabresi, con le varianti dell’incesto e del parricidio, che fanno dire a Crupi che lo scrittore di Acri ha un rapporto agonistico con la stesso modello di Byron.
Antonello
Con questo dramma in cinque atti del 1850 Padula instaura una sorta di congedo da Byron, nel senso che non la letteratura prevale ma lo sguardo sulla vita reale, fatta di contadini, briganti, politici borbonici di malaffare, sullo sfondo di una Calabria baronale dominata da violenza e volgarità. Vari personaggi s’incontrano lungo questo variegato filone narrativo. Antonello che viene rifiutato dai fratelli Bandiera, per non macchiare la causa italiana, Giuseppe che diventa anche lui brigante per vendicarsi del sindaco Brunetti, un’autentica carogna, che chiede a Giuseppe di uccidere il figlio Luigino al suo posto e in un susseguirsi di delitti, la scena si conclude nel carcere di Cosenza, dove Antonello viene fucilato nel lacerante rammarico per il rifiuto del suo aiuto da parte dei Bandiera .
L’opera è attraversata dal realismo cattolico di ascendenza manzoniana. Padula, ma non solo lui, appartiene a quella corrente che potrebbe definirsi di cattolicesimo liberale, così come è stata delineata da Manzoni, ma nella rappresentazione del brigante addita le cause politiche e sociali della ribellione, individuandole nel sistema di governo borbonico e nei rapporti ancora feudali prevalenti nel debole tessuto economico della sua terra.
Dopo l’Unità, oltre a coltivare la poesia, non senza qualche compiacimento edonistico, si dedica a Il Bruzio, la rivista che esce per un anno dal 1864. Negli articoli, quasi tutti di sua composizione, rappresenta le condizioni delle classi subalterne con vivezza d’immagini e puntualità d’analisi, specie quando parla di contadini e di braccianti. Il suo interesse è per le persone, colte nella vita quotidiana in una ragione in cui difficilmente intravede motivi di speranza e di riscatto, in questo non aiutato certo dall’esito moderato del Risorgimento, di cui denuncia i limiti nel Mezzogiorno, pur senza arrivare agli eccessi della reazione borbonica o clericale, ma vagheggiando soluzioni avanzate nel senso della democrazia liberale di vaga ascendenza risorgimentale.
Il focolaio di Acri
Si tratta di un folto gruppo di poeti, o “rimatori” secondo Reina, che si sono formati con insegnanti privati, in prevalenza religiosi, o nei seminari di San Marco Argentano, di Cassano Jonio e della vicina Bisignano e ancora nel collegio italo-greco di San Demetrio. Ne sono stati schedati una ventina e non c’è dubbio che guida indiscussa del gruppo è Vincenzo Padula, di cui si accoglie in pieno la lezione letteraria sia sul piano nazionale che su quello regionale. Il gruppo sopravvivrà, pur senza mai assumere caratteri di organicità, sia alla conclusione del Risorgimento sia alla scomparsa di Padula, ma perderà la sua carica innovativa e rivoluzionaria per rifluire nel canto dei sentimenti domestici, delle glorie locali e nell’esaltazione del municipio. Ha ragione Crupi: “la Calabria non aveva mai sofferto di chiusura provinciale e di astioso separatismo letterario. Avviene con il focolaio di Acri, che quanto più è aperto, nel suo insieme, sul piano politico, tanto più si manifesta conservatore in letteratura.”
Pietro Giannone può essere assunto ad emblema del gruppo, tanto che De Sanctis lo annovera “tra i campioni della novella calabrese”. L’opera meglio riuscita è senz’altro Lauretta, pubblicata a Palermo nel 1839, ma non vanno dimenticate le altre come Un viaggiatore in Pompei, del 1832, La vita campestre di un calabrese, 1833 la raccolta di sonetti Patria e Dio, gli Elogia del vescovo Bellusci e del Beato Angelico. Membro di varie Accademie, dalla Tiberina alla Cosentina, ma fa sempre ritorno ad Acri, luogo di elezione per l’esercizio della poesia e, in genere, della letteratura.
Vincenzo Molinari (1806-1886) studia nel seminario di Cassano e successivamente si iscrive alla facoltà di medicina a Napoli, senza però riuscire a laurearsi. I suoi interessi infatti sono ben altri: partecipa al Vocabolario universale della lingua latina di Nicola Comerci, pubblicato a Napoli nel 1831 e fonda una scuola privata ad Acri, nella quale adotta metodi d’insegnamento moderno sia nel metodo che nei contenuti. Nella rivoluzione del ’48 si distingue nella battaglia di Campotenese, che segna la sconfitta del moto cosentino e, di conseguenza, la fine della sua scuola. Vivrà come sorvegliato speciale della polizia e solo dopo l’unità si trasferisce a Napoli dove ottiene un modesto impiego.
Alla scuola privata del Molinari si forma in un primo tempo Nicola Romano ((1835-1898), che completerà gli studi nei seminari di San Marco Argentano e di Bisignano. Divenuto sacerdote non riesce ad ottenere la parrocchia di Acri e fonda allora una propria scuola privata. Non nasconde le sue idee liberali, provocando così provvedimenti disciplinari delle autorità ecclesiastiche, come la sospensione a divinis, a causa di una sua canzone sui Vespri siciliani. In letteratura si dedica a vari generi, dalla poesia epica, alla lirica e alla poesia drammatica, senza rinunciare a proporre studi critici non proprio trascurabili, specialmente su Dante. Vive, come tanti cattolici e sacerdoti del suo tempo, il contrasto tra fedeltà all’ordine sacerdotale e fervore liberale, risolto quasi sempre a favore degli ideali di libertà e di indipendenza della patria. Tra le sue opere, pubblicate a Risorgimento ormai concluso, si segnalano il dramma Ettore Benincasa, edito a Napoli nel 1871, i sei canti di Marco Berardi o re dei boschi, Napoli 1877 e Benevento 1886, la tragedia Agesilao Milano, Nola 1897, una raccolta di Sonetti del 1895 e, fra gli studi critici, Discorso sulle opere di Alessandro Manzoni, Napoli 1873 e L’ira di Dante giustificata nella storia, Napoli 1891.
Tra i poeti di Acri si distingue Mariannina Giannone (1856-1893), autrice di versi ispirati ai valori della casa, della famiglia e della religione, a riprova della condizione della donna in certe realtà calabresi relegata alle funzioni di madre premurosa e moglie fedele, dopo essere stata figlia rispettosa e devota.
Altro alunno del Molinari è Vincenzo Julia, nato ad Acri nel 1838, avvocato e letterato, impegnato sul piano civile e sociale. Il padre Antonio è avvocato e medico, la madre è sorella di Ferdinando Balsano (1826-1869), prete liberale, seguace della filosofia di Rosmini e del pensiero di Gioberti. Dallo studio di questi tre intellettuali Julia riceve un’educazione liberale aperta alle ragioni del nascente socialismo. La sua produzione letteraria è regolata su principi ai quali fa riferimento ancora nel 1882, scrivendo ad un amico: ”La mia fede è democratica e la poesia (…) è per me un civile apostolato, una protesta contro la tirannide e le ingiustizie del mondo.” Sonetti e liriche, del 1888, sono l’opera poetica più notevole, in cui le condizioni delle plebi contadine e dei braccianti, l’arretratezza feudale della Calabria e l’ansia per la situazione politica italiana, specie dopo l’Unità, sono i temi più ricorrenti. Da ricordare la sua intensa attività pubblicistica sui giornali cosentini del tempo (“L’Avanguardia”, “La Sinistra”, “La Calabria letteraria”) e su riviste meridionali e nazionali. E’ un poligrafo, come tanti intellettuali calabresi di ieri e di oggi, e i suoi interessi spaziano dalla storia alla letteratura e alla filosofia,, con studi sul Medio Evo, Socrate, Manzoni, Vincenzo Monti e via dicendo. Rimasto vedovo con quattro figli piccoli, rimane ad Acri a proseguire l’attività letteraria paterna. E nel 1869 perde anche lo zio Ferdinando, ucciso da un cameriere del convitto di Cosenza che Balsano aveva fatto espellere, e un anno dopo muoiono i genitori. Ad Acri continua a esercitare la professione di avvocato e a coltivare gli studi di diritto e di letteratura, fino alla morte avvenuta nel 1894. Di Vincenzo Julia ha colto da par suo i tratti essenziali Pasquino Crupi: “La Calabria, non l’Italia, piange il poeta montanaro, che aveva alzato il suo verso contro gli oppressori della plebe, il letterato, che più di ogni altro aveva fatto per far correre dentro la storia e la cultura nazionale gli Eroi, i Filosofi, i Poeti dell’estremo Sud, l’intellettuale democratico e socialista, che si era battuto per cancellare la tirannide delle cricche local-nazionali “.
Bibliografia
Pasquale Falco (a cura di), Cultura romantica e territorio nella Calabria dell’Ottocento, Cosenza, Edizioni Periferia, 1987
Pasquino Crupi, Storia della letteratura calabrese – Autori e Testi, III, Ottocento, Cosenza, Periferia, 1995
Pasquale Tuscano, Letteratura delle regioni d’Italia – Calabria, Brescia, Editrice La Scuola, 1986
Carlo Muscetta, Ritratto di Vincenzo Padula, in “Il Ponte”, anno VI, n.9-10, settembre – ottobre 1950, pp. 1105-1120
Gaetano Cingari, Romanticismo e democrazia nel Mezzogiorno – Domenico Mauro (1812-1873), Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1965
Antonio Piromalli, La letteratura calabrese, Napoli, Guida, 1977
Biagio Miraglia, Il brigante, introduzione di Luigi Reina, con un saggio di Enrico Esposito, Biagio Miraglia storico e politico, Lungro, Marco Editore, 1996